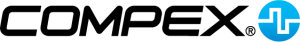Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
|
||||
|
di GEORGE BLUME Sono gli spettatori impauriti, il pubblico terrorizzato di questi giorni drammatici a Lhasa. Gli attori appaiono diversi. Nel locale se ne stanno seduti anche due giovani. Uno ha i capelli lunghi e una giacca di pelle abbottonata. L’altro ha un cappello di lana calcato sul viso. Sembrano quasi dei giovani occidentali. Sono gli unici che non balzano in piedi. Immobili, restano fermi sulle panche, non allontanano lo sguardo dalle scodelle di zuppa e dalle tazze di tè. Sono le persone come loro il motivo per cui il mondo guarda adesso verso il Tibet. Né il Dalai Lama né il Partito comunista cinese li avevano messi in conto. Venerdì scorso hanno organizzato nella capitale tibetana Lhasa delle proteste violente e distruttive. Pochi giorni prima i monaci buddisti avevano iniziato le prime dimostrazioni. Ma questi giovani incolleriti incarnano un altro Tibet, un Tibet nuovo. Dopo le proteste di venerdì qui non è rimasto molto dei negozi cinesi. Il quartiere offre un’immagine di terribile distruzione. Avvolgibili metallici strappati, banconi demoliti, frigoriferi ammaccati, auto e biciclette bruciate – tutto a mucchio in mezzo alla strada, tra pietre e cocci. La montagna di rottami è ancora fumante. Puzza di gomma bruciata. Intere hall degli hotel sono carbonizzate, banche per metà scassinate, alcuni negozi di generi alimentari o di attrezzi completamente distrutti e svaligiati. Accanto passa una pattuglia di blindati, muovendosi a zigzag tra i resti della rivolta. I loro cingoli stritolano quel ciarpame. «Ci proteggono», dicono i cinesi ai lati della strada. «Non ci mettono paura», dicono i tibetani. Sono gli uni al fianco degli altri. Poche centinaia di metri più in là ai cittadini di Lhasa si presenta uno spettacolo militare di tutt’altra dimensione. Sulla North Linkuo Road, la strada da Potala al monastero di Sera, sfila la polizia militare in servizio effettivo. A un gruppo di blindati in testa alla colonna seguono all’incirca duecento pick-up militari verdi. Sopra, unità armate di mitragliatrici, 30 uomini per ogni mezzo, in tutto 6.000 persone, per la maggior parte giovanissimi. Indossano una divisa militare verde, un elmetto e una fascia rossa sulla parte superiore del braccio. In cima alla cabina di guida due fucili a tiro rapido sostenuti da alcuni supporti puntano verso la folla di curiosi sui marciapiedi. Nella colonna si trovano anche mezzi della Croce Rossa e camion blindati. E subito si pensa al giugno 1989. Zhang Lizhong dell’Ufficio per le questioni estere della regione autonoma del Tibet non ne vuol sapere di un paragone col massacro di Tienanmen. I tumulti di venerdì avrebbero provocato, secondo quanto appurato dalle indagini fino a lunedì, la morte di 13 civili – nessuno ucciso dalla polizia, ma da ustioni, sassate e pestaggi, «vittime della plebaglia», come dice Zhang. Le sue affermazioni non sono del tutto erronee. Gli enormi danni materiali testimoniano la notevole violenza dei dimostranti. Il governo tibetano in esilio in India parla di molte più vittime tra i manifestanti, di cento morti, a causa dell’intervento brutale delle forze di sicurezza cinesi. Anche ciò appare plausibile, a causa dello spiegamento di migliaia di poliziotti pesantemente armati. L’ong «Centro per i diritti umani e la democrazia» in India ha contato finora 55 morti. Molti a Lhasa sono convinti che si sia trattato di un massacro della polizia militare. «È terribile. Hanno ucciso così tanti dei nostri», grida una vecchia tibetana in abito blu e rosso scuro. La donna si trova in un vicolo vicino il tempio Jokhang, in cui monaci hanno ordito la rivolta. Scompare velocemente dietro l’angolo della prossima casa non appena si vede rivolta la parola. Chi dimostrerà la verità sulle dimensioni della repressione? In ogni caso non i media, né quelli statali censurati in Cina, né quelli liberi occidentali. Sabato scorso non c’era nessun ostacolo rilevante per i giornalisti occidentali per raggiungere Lhasa, tranne un burocratico permesso di viaggio, che di regola viene controllato solo alla reception degli hotel. Non c’erano dunque ostacoli per i reporter, finché, lunedì, la polizia cinese per gli stranieri li ha invitati gentilmente a tornare a Pechino. Ma per quanto riguarda il numero di vittime che il regime e i movimenti di protesta citano non è possibile per il momento ottenere delle prove. Due delle persone che hanno partecipato alle proteste siedono il giorno dopo le dimostrazioni in un locale vicino Al palazzo del Potala. Indossano scarpe da ginnastica e giacche a vento, chiedono pasta in brodo e birra. Sono di buon umore: ieri i tibetani hanno fatto vedere ai cinesi di cosa sono capaci, spiegano. Anche il Dalai Lama la vede così? «Nessuno ci aiuta. Nemmeno Dio», rispondono. Ovviamente sanno che il Dalai Lama vuole risolvere le cose pacificamente, dicono. Lo adorano, vorrebbero che tornasse: non possono certo andare loro da lui in India, affermano. Ciò suona abbastanza disinvolto e piuttosto distante dalla fede. I due rappresentano però la nuova gioventù a Lhasa: urbana, libera da preconcetti, orientata al benessere e senza paura. I tibetani del ristorante nella strada Oumi o i monaci Za e Dang portano il dito davanti la bocca non appena si parla del Dalai Lama. Non vogliono rompere la loro lealtà nei suoi confronti, anche se in Cina viene considerata un crimine. I giovani in giacca a vento parlano invece di lui in modo spensierato, sebbene a grande distanza. Chiariscono subito che la rivolta appartiene soltanto a loro. Raccontano i loro motivi, che non hanno avuto nessuna possibilità di una normale formazione scolastica, che trovano sempre lavori pesanti, mentre i cinesi nello stesso momento diventano ricchi a loro spese. Spiegano che i tibetani ottengono solo lavori pagati male e che i cinesi vengono pagati meglio per la stessa occupazione. Si lamentano che un paio di jeans adesso costa 70 invece di 30 yuan, come finora (7 invece di 3 euro). «I cinesi ci rubano il nostro lavoro e i nostri soldi». I monaci tibetani e questi giovani vivono in due mondi diversi. Gli uni non hanno ancora mai parlato con uno straniero, gli altri incontrano continuamente turisti occidentali. Oggi ci sono in Tibet due vite differenti, quella monastica e quella nei primi passi verso la globalizzazione. La rivolta si nutre di entrambe queste vite. Ma come fa a servire interessi così diversi? All’inizio sono i monaci che vanno avanti. Dimostrano anche in altre province cinesi. Hanno una strategia politica, approvata dal Dalai Lama, che punta ai Giochi olimpici e alle pressioni da parte dell’opinione pubblica internazionale. Se però l’enorme dispiegamento di forze di sicurezza a Lhasa significa qualcosa, questo qualcosa è che Pechino non cederà a simili pressioni. Sulla questione del Tibet il governo comunista sa che il 95% dei cinesi è al suo fianco. Tanto più drammatica è la situazione dei giovani a Lhasa. Hanno perso la testa per un giorno. Adesso devono pagare un conto salato per questo. Gli sgherri del governo sono già in giro. «Ieri sera e stamattina i poliziotti hanno portato con sé dei giovani in due camion», racconta lunedì la cameriera di un locale, in cui due giorni prima sedevano i due ribelli di buon umore. Forse siedono già in carcere, rischiano la tortura e pesanti pene. Malgrado tutta la simpatia occidentale e l’entusiasmo dei media per il Tibet: in caso di emergenza ciò aiuta poco le persone coinvolte. Può però portare facilmente i protagonisti a sopravvalutare le loro forze. Tutto il baccano sul Dalai Lama, la sua grossa stima politica nelle capitali occidentali non cambia nulla nel fatto che i tibetani hanno a che fare soprattutto con i cinesi. E ora di nuovo con i peggiori, i militari nei vertici di Pechino. I tibetani hanno bisogno di una strategia con la Cina, non di una strategia contro la Cina. Copyright «Die Zeit» |
||||
|
||||
|
 LHASA, 20 marzo 2008 – Le sirene urlano. Il pavimento del piccolo ristorante inizia a tremare. I clienti sentono il ronzio delle motociclette e il tremendo rumore di catene. Saltano su dalle panchine di legno, si precipitano alla finestra, scostano le tradizionali tendine tibetane coi simboli della buona sorte attaccate alle porte. I clienti sono giovani e vecchi, alcuni indossano i locali ornamenti colorati per i capelli. I loro volti sono in parte oblunghi e marrone scuro, in parte rotondi e chiari come quelli dei cinesi. Su tutti regna però in questo momento lo stesso spavento. Soprattutto nelle donne si nota una profonda paura – come se dovessero arrivare ora i cinesi per sottrarre i loro bambini. Fuori prendono posizione i mezzi blindati della polizia militare cinese – pesanti cingolati grigio-marroni. Su ognuno dei loro posti di vedetta ci sono sei poliziotti militari con dei fucili premuti contro le loro spalle. Le baionette argentate scintillano al sole di mezzogiorno. Con lo sguardo fisso osservano i numerosi passanti in basso. Sono tibetani e cinesi, mischiati in egual misura. I clienti tibetani del locale prima ricambiano gli sguardi provenienti dai cingolati, poi li discostano, schiumanti di rabbia. Alcuni inveiscono, mentre tornano ai loro tavoli di legno dipinti a fiori.
LHASA, 20 marzo 2008 – Le sirene urlano. Il pavimento del piccolo ristorante inizia a tremare. I clienti sentono il ronzio delle motociclette e il tremendo rumore di catene. Saltano su dalle panchine di legno, si precipitano alla finestra, scostano le tradizionali tendine tibetane coi simboli della buona sorte attaccate alle porte. I clienti sono giovani e vecchi, alcuni indossano i locali ornamenti colorati per i capelli. I loro volti sono in parte oblunghi e marrone scuro, in parte rotondi e chiari come quelli dei cinesi. Su tutti regna però in questo momento lo stesso spavento. Soprattutto nelle donne si nota una profonda paura – come se dovessero arrivare ora i cinesi per sottrarre i loro bambini. Fuori prendono posizione i mezzi blindati della polizia militare cinese – pesanti cingolati grigio-marroni. Su ognuno dei loro posti di vedetta ci sono sei poliziotti militari con dei fucili premuti contro le loro spalle. Le baionette argentate scintillano al sole di mezzogiorno. Con lo sguardo fisso osservano i numerosi passanti in basso. Sono tibetani e cinesi, mischiati in egual misura. I clienti tibetani del locale prima ricambiano gli sguardi provenienti dai cingolati, poi li discostano, schiumanti di rabbia. Alcuni inveiscono, mentre tornano ai loro tavoli di legno dipinti a fiori.