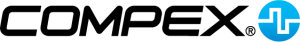Mezza, un quarto, mezza, tre quarti, tutta
Mezza, un quarto, mezza, tre quarti, tutta
 Ore 12.18. Portando sottobraccio i remi mi dirigo lentamente verso il pontile d’imbarco. Il remo è la spada del canottiere, diceva il mio vecchio allenatore, Nino Gomez, con le sue immagini magniloquenti, mutuate a volte da reminiscenze dantesche o del teatro d’opera, a volte da ricordi di prigionia bellica, ed aggiungeva: tenilu sempri davanti, comu i cavaleri antichi tinevanu a spada. Mancano ancora tre quarti d’ora alla gara, giusto il tempo per scendere tranquillamente in acqua e fare un buon riscaldamento.
Ore 12.18. Portando sottobraccio i remi mi dirigo lentamente verso il pontile d’imbarco. Il remo è la spada del canottiere, diceva il mio vecchio allenatore, Nino Gomez, con le sue immagini magniloquenti, mutuate a volte da reminiscenze dantesche o del teatro d’opera, a volte da ricordi di prigionia bellica, ed aggiungeva: tenilu sempri davanti, comu i cavaleri antichi tinevanu a spada. Mancano ancora tre quarti d’ora alla gara, giusto il tempo per scendere tranquillamente in acqua e fare un buon riscaldamento.
Mentre cammino curvo sotto l’imbarcazione, ripenso a tanti, tanti anni passati: I canottieri sono una casta, ci diceva sempre Gomez, a sottolineare la difficoltà del nostro sport, fatto di disciplina e non di gioco, ed insieme la superiorità morale e fisica di chi sceglie di diventarne seguace. E ci ripeteva, fino allo sfinimento, la lezione del canottaggio: combattere ogni battaglia con tutte le nostre forze e vincere, in primo luogo su noi stessi. Le levatacce alle sei del mattino, al freddo d’inverno, per correre al capannone del circolo canottieri, uscire in barca e poi, sempre di corsa, a scuola. Le uscite in barca interminabili, d’estate, ad occhieggiare le ragazze alla spiaggia della Plaja; il bagno col remo (avevamo inventato, a nostra insaputa, la talassoterapia). Sono passati quasi vent’anni: se fossi un vogatore a tassametro, un tanto a palata, oggi sarei milionario! E il vecchio capannone del Circolo: il giorno in cui fu demolito resta per me al secondo posto tra i giorni più brutti della mia vita, subito dopo quello della morte di mio padre. Si trovava proprio a fianco della Capitaneria di Porto, dove adesso sorge un orribile casermone giallo collegato da una specie di corridoio strozzato all’edificio più antico. E penso che la conclusione è amara: dove era un luogo di svago, ma soprattutto di crescita ed educa-zione, oggi hanno fatto un attracco per navi traghetto.
Con la coda dell’occhio, facendo finta di niente, ho già controllato gli altri singolisti che, anche loro, con studiata indolenza, stanno sistemando i numeri di corsia sugli scafi e si accingono a scendere in acqua. Come sempre avviene, ieri eravamo tutti insieme, al deposito imbarcazioni, dopo l’ultimo allenamento, a scherzare ed a ridere su vecchie gare; oggi, con le facce più tirate dei bicipiti, fissiamo le immagini dei platani riflesse nelle acque ferme del lago, cercando la concentrazione.
Ore 12.22. In culo alla balena! Con il tradizionale augurio, la mano di Mimmo lascia la pala del remo, spingendomi fuori. Adesso sono proprio solo, come temevo, come volevo. Lentamente, comincio a remare. Seguendo un rituale più scaramantico che di effettiva utilità (anche se c’è chi giura sulla necessità di non iniziare a remare direttamente a carrello pieno, per evitare traumi e strappi alla schiena), dapprima una diecina di palate date solo con le braccia; poi anche con le spalle; infine, percorsi cento duecento metri, comincio a muovere il carrello ed a portare il colpo, cercando man mano sempre più l’ampiezza e la profondità. Nell’aria immobile e calda, il rassicurante movimento del carrello che scivola sui cuscinetti ben oliati mi dice che ogni cosa è come dovrebbe essere. Ogni dettaglio ogni colore ogni odore, è come dilatato ed esaltato dalla luce che si riflette sull’acqua ed irraggia di sé, diffondendosi in particelle minute, alberi, terra, su fino al borgo medioevale che si protende sul lago.
Ore 12.29. Olaa via! Olaa via! Aumentare!! In un crescendo di urla e di fervore emotivo, i due con stanno venendo su. Incrocio le punte delle imbarcazioni mentre transitano dalle boe che segnano gli ultimi cinquecento metri di passione. I timonieri ruggiscono (via le spalle! Via! Ancora dieci colpi!!) il loro disperato incitamento ai compagni, tesi nello spasmo di tirare fuori ancora qualcosa dall’impasto di carne e di sangue, non più illuminato dalla consapevolezza di sé, che il vogatore sente di essere a questo punto del percorso. Eravamo ai mille e cinque, si dice, raccontando ai compagni il momento decisivo della regata, quando si tratta di spremere le ultime forze, strizzando cuore, muscoli e polmoni quasi si trattassero di spugne malamente intrise d’acqua. Solo il canottaggio è così bello e così terribile. Tiro qualche palata più intensa e comincio a sudare.
Ore 12.44. Equipaggi, siete pronti? Via! Il giudice di partenza ha lasciato andare la gara che precede la mia. Guardando le barche che si allontanano, rilasciando nell’acqua una doppia fila, perfettamente simmetrica, di fiori concentrici con ai bordi un po’ di spuma biancastra, che si richiudono subito dopo, entro nel campo di regata. All’altezza dei barchini del via, provo anch’io un paio di partenze. Mezza, un quarto, mezza, tre quarti, tutta. Le palate si infrangono l’una sull’altra contro l’acqua placida e stupita, la barca scivola via veloce, mentre io sento le braccia già stanche ed il cuore che batte all’impazzata. E la fatica deve ancora cominciare. Rivedo il titolo di una vecchia rivista, E secondo mie forze anch’io pugnava, che intendeva magnificare, con aristocratico compiacimento, il remo e la sua fatica. Ed in realtà mi rendo conto, guardando nei visi e nelle espressioni sempre più tirate dei miei avversari (con molti siamo diventati adulti insieme, nell’unica consuetudine che unisce ed accresce, quella del confronto accanito, puntiglioso e leale), che stranamente chi, per caso o per vocazione familiare, comincia a remare, non riesce più a smettere: stranamente dico perché remare è attività antica e sfibrante, del tutto priva di narcisistici consensi, come pure disgiunta da materiali soddisfazioni. Un passatempo per gentiluomini, diceva mio padre.
Ore 12.50. Singolo senior, alla partenza. Ora il giudice chiama gli equipaggi, che rispondono alzando un braccio ed, ubbidienti (ma non si può fare resistenza), si allineano sulla partenza. Vi è un che di simbolico, forse, nella docilità con cui le barche attraversano il campo di regata e prendono la posizione nella corsia d’acqua: il percorso di gara, desiderato e temuto insieme, come un paradigma impietoso nel quale ci riflettiamo tutti, con le nostre paure, i nostri desideri, le nostre ambizioni, nel quale è così forte, talvolta, la tentazione di risparmiarsi, di non soffrire e non spingere ogni palata fino in fondo, fino a sentire il sapore del sangue che brucia la gola, mentre spalanchi la bocca per riempire il più possibile di aria i polmoni.
Ore 12.59. Cus Catania, una palata indietro. Con il braccio alzato per far capire all’arbitro che non sono ancora pronto, cerco di orientare la direzione. Mi giro e distinguo a malapena il muraglione che delimita il lago, a 2000 metri di distanza. In partenza si cerca di non pensare, di lasciare che il corpo compia automaticamente i movimenti necessari, ma mi angoscia, come ogni volta, il non riuscire a vedere le bandiere di arrivo che, tra circa sette od otto minuti, segneranno la fine della sofferenza. Come sempre, anche se non c’è ne è bisogno, controllo la chiusura delle scalmiere, dove i remi diventano un tutt’uno con l’imbarcazione, le viti che saldamente infiggono la scarpiera al fondo barca, la corsa del carrello. Sono gesti ripetuti ormai meccanicamente, nella speranza di esorcizzare la paura della fatica che, lo so bene, mi attanaglierà il cuore e la mente non appena appoggerò le pale in acqua in posizione di partenza ed aspetterò che lo starter sollevi la bandiera rossa e dia il via. Mezza, un quarto, mezza, tre quarti, tutta. Un passatempo per gentiluomini. Voglio dirlo a mio figlio, appena torno a casa.
FRANCESCO PULEIO
Francesco Pulejo, procuratore aggiunto del Dipartimento Investigativo Antimafia della procura di Catania. In Sicilia è il tesserato in attivo con più anni di gare alle spalle, ed è stato atleta di buon valore della Jonica e poi del CUS Catania.
Il testo ha partecipato al concorso letterario del CONI di quest’anno.